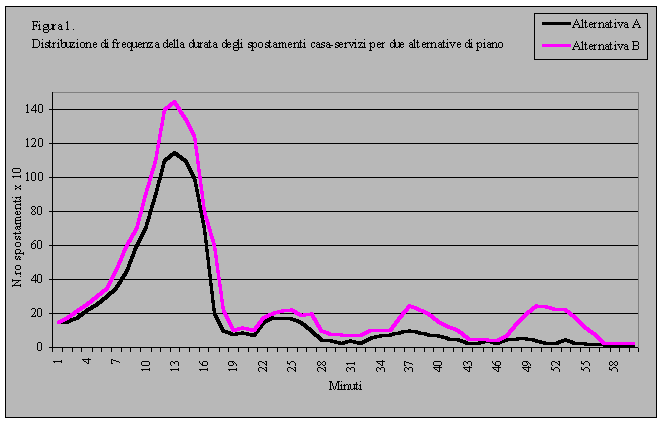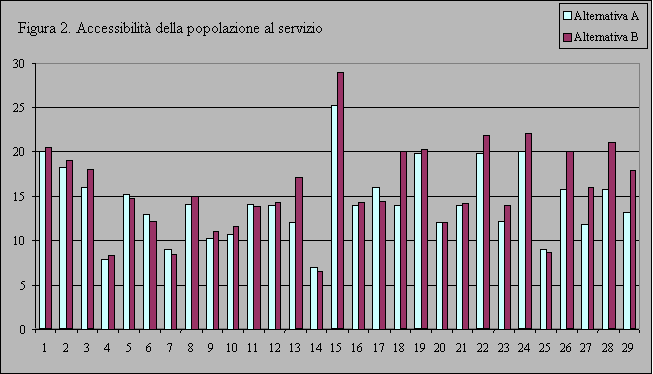Informazione,
pianificazione e gestione del
territorio
SILVANA
LOMBARDO
Docente Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria
Dipartimento di Ingegneria Civile
1.
Introduzione
La pianificazione la gestione del territorio sono strettamente connesse ad un insieme di operazioni di valutazione che riguardano diversi sottosistemi del sistema territorio: il sottosistema sociale, quello ambientale, quello fisico, quello finanziario, e quello funzionale, nonché l’evoluzione di tali sottosistemi.
Pianificazione e gestione si applicano a tali sottosistemi e ciascuno di essi richiede approcci specifici e tecniche appropriate di valutazione che, a loro volta, devono essere basati su un appropriato livello di conoscenza.
Uno dei relatori che mi ha preceduto affermava che “Occorre conoscere per valutare”: è da aggiungere che, nel momento in cui la conoscenza ha una sua struttura ben chiara, descrivibile e comunicabile, diventa trasferibile e può aiutare a raggiungere l'obiettivo della trasparenza, vale a dire della trasparenza nella discussione, nella negoziazione anche con le Opposizioni, della trasparenza nelle decisioni.
Abbiamo bisogno, quindi, di conoscere ed abbiamo un certo fabbisogno informativo.
2. Sul fabbisogno informativo
È da notare che il fabbisogno informativo non è conosciuto una volta per tutte, esso si costruisce mano a mano che le politiche vengono implementate e mano a mano che i problemi e la loro consistenza vengono percepiti. Inoltre il fabbisogno informativo, mentre da un lato fa riferimento a questioni basilari generalizzabili (basic needs), dall’altro si colora di specificazioni fortemente caratterizzate dalle diverse situazioni geografiche e temporali.
Un rilevante fabbisogno informativo al quale fare
riferimento è quello relativo alla assunzione di decisioni e alla elaborazione
di politiche per le aree urbane.
Poiché il concetto di informazione è strettamente
legato alla esistenza di una domanda e, dunque, alla esistenza di reali e
diffuse preoccupazioni alle quali è necessario dare risposta, il ragionamento
si sviluppa con l’analisi dei gradi successivi di un processo di conoscenza
finalizzato all’azione.
In Anderson, A. e Johansson, B. (1986), troviamo la
descrizione di un processo che dalla informazione (che gli autori
assimilano ai dati) procede verso la conoscenza, la competenza e
la creatività.
Senza ripercorrere l’intero ragionamento degli autori
ai quali si rimanda, qui, partendo dalle loro definizioni, aggiungiamo quei
requisiti che il caso in esame richiede:
ü
la conoscenza
deve essere condivisa, cioè accessibile e, soprattutto, fondata sul
bisogno condiviso di informazione (dunque partecipata);
ü
la competenza è
una conoscenza finalizzata all’azione o alla costruzione di strumenti
per l’azione. Si tratta dunque di restringere o di allargare il campo della
informazione attorno a quei campi per i quali si sta agendo o si vorrebbe
agire;
ü
la creatività dipende, fra l’altro, dalla capacità di confrontare
l’esito delle politiche nelle diverse situazioni valutandone efficacia ed
efficienza, ma dipende soprattutto dalla capacità di generare sinergie positive
fra componenti geografiche diverse e fra settori e programmi di investimento
distinti, fra i gruppi molteplici di attori.
In queste pagine viene proposta una possibile
articolazione del fabbisogno informativo che analizza le ‘emergenze principali’
delle aree urbane, identificando per esse il quadro delle preoccupazioni (e
delle sub articolazioni) e il quadro degli indicatori di livello e di tendenza
e i segnali delle politiche e del relativo successo.
Le
città sono oggi al centro di una triplice emergenza: una emergenza sociale,
una emergenza economica ed una emergenza territoriale e ambientale.
Tali emergenze costituiscono altrettante preoccupazioni fondamentali su cui
concentrare le azioni di conoscenza e monitoraggio, al fine di iniziare a
prefigurare politiche urbane unitarie coordinate.
Le principali emergenze delle aree urbane e il
relativo fabbisogno informativo si possono riassumere come segue:
A)
L’emergenza
sociale
Si tratta di una attenzione ai gravi fenomeni di
disadattamento alla vita sociale e comunitaria che appaiono con la massima
evidenza nelle aree ad alta concentrazione in cui, a quella che i sociologi
hanno definito una nuova solitudine fra la folla, si accompagnano drammatici
fenomeni di microcriminalità, di disinserimento e di mancanza di integrazione
fra le classi e, soprattutto fra le diverse etnie che sempre più sono presenti
nelle aree urbane del nostro Paese.
Agli aspetti
che per la loro drammaticità occupano un posto rilevante nella immagine della
nostra società si accompagnano quelli diffusi e, apparentemente meno
importanti, con i quali siamo abituati a convivere, ma che per questo non sono
meno gravi. Ci si riferisce all’abbandono della scolarità e ai frequenti fenomeni
di incomprensione con le strutture della scuola da parte dei giovani e delle
loro famiglie, alla disparità di accesso ai servizi, sia a quelli che
riguardano il soddisfacimento di bisogni elementari come di quelli che
assicurano la possibilità di coltivare la propria personalità, la cultura e lo
svago, le forme di partecipazione alla vita comunitaria.
Se spontaneamente si tende a guardare con attenzione
prioritaria i problemi delle classi giovani, non meno gravi sono quelli degli
anziani e dell’infanzia e le relative interferenze con le classi intermedie.
Allo stesso modo dovranno essere considerate con particolare attenzione le
altre classi ‘deboli’, ciascuna delle quali impone un ulteriore arricchimento
di concetti e politiche.
Le preoccupazioni riferite a questa emergenza (le cui
componenti vengono indicate solo a titolo di esempio) si collegano in larga
parte, anche se non esclusivamente, agli intensi fenomeni di inurbamento, che
il nostro Paese ha conosciuto soprattutto a partire dal dopoguerra, i quali
hanno provocato, da un lato, sradicamento e dall’altro, la sostituzione di
modelli insediativi e di relazioni fisiche e sociali che si erano consolidati
attraverso i secoli con modelli disegnati sotto la spinta prevalente e
determinante di una domanda insediativa e di accentramento tumultuosa.
Le misure e le politiche indirizzate in queste
direzioni investono tanto le strutture di funzionamento della nostra società
quanto la dotazione di infrastrutture e non avrebbe senso considerare le une
senza considerare le altre: ci si riferisce alla indispensabile attenzione alle
forme d’uso che gli spazi e le infrastrutture sono capaci di attirare.
Lo schema in Tabella 1 presenta in forma sintetica e
sistematica – seppure in via esemplificativa – un quadro sinottico del
fabbisogno informativo, presentando gli indicatori di livello e di tendenza,
delle politiche e dei trend e di valutazione dei risultati; l'ambito è
articolato nei sottodomini che investono:
·
la emarginazione delle
classi deboli o a rischio,
·
l’isolamento che intere
zone urbane presentano rispetto ai consueti canali delle comunicazioni;
·
le telecomunicazioni,
·
la possibilità di adire
all’insieme delle opportunità di svago, di formazione o di partecipazione a
manifestazioni culturali o dello spettacolo e quant’altro contribuisca a
definire i caratteri della vita urbana.
Questa articolazione, seppure non esaurisce il tema,
lo scompone nei segnali di maggiore evidenza del malessere determinato dalla
emergenza sociale.
B) L’emergenza economica e l’occupazione
Nel quadro globale della economia, gli anni recenti
hanno presentato motivi di preoccupazione
dipendenti che vanno dalle dimensioni eclatanti della crisi
occupazionale delle economie ‘sviluppate’ al freno dei meccanismi della
crescita economica, alle oscillazione dei mercati finanziari e delle valute.
Mentre nelle sedi appropriate si discute sul ruolo
dell’indebitamento nelle fasi di stagnazione, per quanto attiene alla economia
delle città, numerosi sono i segnali ai quali bisogna guardare interrogandosi
su un nuovo significato della pianificazione in contesti di recessione.
La prospettiva dell’analisi è rivolta alla
problematiche di breve a quelle di lungo periodo (Tabella 2). Per quanto
attiene a quest’ultimo ricordiamo come numerosi siano gli autori che con
maggiore o minore ricchezza documentaria prevedono radicali cambiamenti dei
modelli di vita (Costa e Toniolo, 1992).
Nello sviluppare tale selezione, si cercherà di porre
in evidenza che possono essere i segnali dei cambiamenti in corso.
B1) Disoccupazione
Il fabbisogno di informazione si articola a partire
dal fenomeno che con più drammaticità
interessa tutte le Regioni d’Europa con i loro 18 milioni di disoccupati. Tale
aspetto viene osservato con riferimento alla dimensione che esso sembra
assumere nelle aree urbane le quali erano state, ma forse sono e saranno ancora
per lungo tempo l’incubatore delle innovazioni da una parte e un serbatoio di
occupazione dall’altro.
La crisi occupazionale investe dunque particolarmente
le aree urbane che da sole assorbono (a seconda del tipo di stima) più del 90%
della domanda di lavoro del Paese.
Essa si manifesta attraverso numerosi fenomeni da
indagare con gli strumenti propri della sociologia e della economia, ma
possiede anche una dimensione riferita allo spazio geografico.
ü Settori economici che hanno perduto posti di lavoro
ü Quartieri che hanno perduto la loro specificità
economica
Il fabbisogno informativo riguarda non solo lo stato
delle infrastrutture, ma anche sui nuovi valori da riconoscere per i siti sia
per gli aspetti intrinseci che per quelli posizionali.
B2) Ineguale distribuzione delle nuove attività
produttive
Le diverse opportunità economiche presenti sul
territorio possono essere valutate alla luce di numerosi indicatori. In questa
sede si pone l’accento sulla capacità endogena delle aree urbane di promuovere
attività innovative: tale capacità costituisce infatti il fattore principale
sul quale fare affidamento per la ripresa economica di una regione urbana.
In questo settore sono stati scelti alcuni aspetti che
certamente non coprono l’intero fabbisogno informativo, tuttavia possono essere
ritenuti, in prima istanza, come segnali rappresentativi delle ineguaglianze:
Con particolare cura dovranno essere approfonditi gli
aspetti relativi a:
ü La rete della distribuzione e degli approvvigionamenti
commerciali
ü Il management immobiliare
ü Prodotti di nicchia
ü La promozione e la commercializzazione dell’offerta
turistica
ü La Ricerca e Sviluppo
ü Le infrastrutture telematiche
ü
I trasporti su ferro
e le aree per la intermodalità.
C) L’emergenza territoriale ed ambientale.
Le grandi trasformazioni territoriali dell’ultimo
cinquantennio hanno posto all’attenzione la gravità dei grandi temi della
difesa del suolo come tratti caratteristici del “rischio ambientale”, legato al
diffondersi di un ‘arcipelago’ di insediamenti.
Nel grande tema del dissesto idrogeologico connesso
agli insediamenti, si innestano poi i temi tipici delle aree più urbanizzate,
entro le quali si alternano i problemi di un territorio costruito o con i modi,
tempi e quantità tipiche del ‘boom’ edilizio o con quelli in cui la corsa alla
seconda casa, da un lato, e l’abbandono dell’agricoltura dall’altro, hanno
determinato una diffusione dell’insediamento incontrollato, gravemente carente
di forme organizzative sia dello spazio che delle attività.
A tali processi si collegano i problemi della
congestione, della disparità nella distribuzione delle opportunità, del degrado
e della obsolescenza.
Per la loro natura di aspetti tipicamente trasversali
che interessano molte discipline, occorre, oggi, innestare forme di analisi e
documentazione che, rifiutando improduttivi caratteri di monosettorialità,
promuovano la conoscenza dei processi di trasformazione dell’ambiente in
stretta relazione con le azioni di trasformazione che l’attività umana produce
nelle aree urbane e nel loro intorno immediato.
Si esamina qui di seguito la composizione dei domini
di informazione di principale evidenza (Tabella 3), che appaiono come quelli
attraverso i quali si possa giungere ad una articolazione operativa concernente
la analisi e la valutazione della emergenza ambiente e territorio.
C1) Le risorse
Il consumo delle risorse e la gestione dei fabbisogni
rappresenta tanto per le grandi come per le piccole aree urbane, l’aspetto di
maggiore interferenza con il sistema Ambientale.
Solo recentemente ricerche di dettaglio su questi temi
tendono ad abbandonare l’esame di singoli casi per tentare una strada di
generalizzazione. Occorre dunque porre i presupposti per generare attorno a
tali questioni una base di informazione e di conoscenza che generi gli
indispensabili elementi di competenza e creatività.
Le questioni di maggiore evidenza riguardano:
ü Acqua
ü Difesa del Suolo
ü Rifiuti
ü Energia
ü Paesaggi e Beni Storici e Artistici
C2) Il sistema funzionale urbano
È generalmente condivisa l’idea che il sistema
funzionale urbano sia l’indicatore più efficace di tutti i problemi che sorgono
in riferimento agli altri aspetti considerati. In effetti in esso si
trasferiscono le questioni complessive del disagio ambientale ed economico
ovvero si trasferiscono effetti, cause e manifestazioni.
Per semplicità espositiva, si elencano sette categorie
di attenzione, selezionando quelle che appaiono di maggiore evidenza.
ü Il disagio abitativo
ü L’abusivismo
ü I trasporti e la congestione del traffico
ü La metropolitanizzazione e il regime degli scambi
ü Le disparità nella dotazione e nell' accessibilità ai
servizi
ü L’obsolescenza e il recupero nei tessuti insediativi
ü Le politiche per l’eccezionalità [1]
3. Processo
di valutazione e fabbisogno informativo
Il processo di valutazione può essere articolato in quattro momenti fondamentali
1) la valutazione dello stato di fatto: conoscere la situazione attuale per mettere in evidenza i problemi e quindi per iniziare a stabilire gli obiettivi;
2) la valutazione ex ante: stimare come e quanto le risorse e le azioni che si intende impiegare possono contribuire al conseguimento degli obiettivi.
Abbiamo bisogno, quindi, di quantificare in che misura possiamo conseguire gli obiettivi (indicatori di efficacia) e quanto ciascuna azione e ciascuna risorsa può contribuire a questo conseguimento (indicatori di efficienza); abbiamo bisogno di effettuare una stima della capacità di produrre risultati positivi da parte di diverse alternative di intervento (comparazione di alternative), di valutare quali condizioni dovranno verificarsi per il successo, quali costi sociali e quali costi ambientali dovranno essere sopportati e in modo particolare di valutare i costi sociali da parte di quale gruppo e i costi ambientali da quali categorie di risorse saranno sopportati.
Soltanto dopo aver effettuato tali stime, si potrà proporre una possibile decisione in merito alla scelta di una delle strategie per realizzare il progetto in questione: se queste non sono soddisfacenti si dovranno produrre ulteriori alternative ed infine si potrebbe decidere di non realizzare il progetto.
3) la valutazione on going: il monitoraggio, necessario a chiarire e tenerci sempre aggiornati sulla validità degli obiettivi rispetto alla evoluzione della situazione al contorno.
4) la valutazione a posteriori, che purtroppo è una delle meno eseguite, attira meno applicazioni e meno attenzione, ma all'estero è molto più sviluppata ed è quella che, invece, potrebbe insegnare moltissimo sulle decisioni da prendere e sulle performances delle procedure stesse di valutazione.
In tale contesto, il fabbisogno informativo va definito in modo accurato.
A seconda del problema, a seconda di quello che si deve valutare, decidere e scegliere, si ha un particolare fabbisogno informativo e si ha bisogno anche molto spesso di un SIT (Sistema Informativo Territoriale), o di una sua parte, appositamente progettato e costruito, la cui architettura riesca a venire incontro al fabbisogno informativo per un particolare insieme di problemi.
Se si vuole trarre informazione dai dati disponibili, statistici e non, è necessario elaborarli con tecniche appropriate, verificando naturalmente la loro affidabilità, soprattutto in presenza dell'attuale costante crescita del volume dei dati disponibili in molteplici forme e da svariate fonti.
Come si è detto, il fabbisogno informativo dipende dalle preoccupazioni e dai problemi che ci si pone in una particolare circostanza, ma i dati devono avere anche alcune caratteristiche tecniche. Ad esempio, devono essere sufficientemente disaggregati per classi di fenomeni, per classi di individui, per classi territoriali. Molto spesso il dato disaggregato a livello comunale per particolari tipi di problemi o di tecniche non è sufficiente e deve essere più disaggregato. Ovviamente questi dati devono essere rilevati in maniera continua, regolare e confrontabile.
L’ultimo punto, che è quello, a mio parere, cruciale, poiché può consentire un grosso salto nella trasformazione del dato “bruto” in informazione sempre più utile e significativa, riguarda il fatto che i dati e le informazioni non devono essere solo relative ai nodi (il Comune o la sezione di censimento o una determinata categoria di popolazione, ecc.), ma anche alle relazioni fra gli elementi e alle relazioni fra i fenomeni.
L’esempio più immediato è quello della mobilità: i flussi di spostamento sia per scopo di lavoro che di studio sui vari mezzi di trasporto.
Questo è un insieme di dati statistici che da solo fornisce moltissime informazioni che sono certamente utili a chi si occupa del settore trasporti, ma che può anche contribuire a costruire informazione finalizzata a valutare lo stato di benessere, la distribuzione di vantaggi o svantaggi fra gli abitanti di un territorio, ecc..
A questo scopo, però, le variabili relazionali devono essere messe in relazione con le caratteristiche puntuali di questi territori.
Un esempio relativo ai problemi territoriali ed ambientali, su come si possono rappresentare dei fenomeni e delle tendenze e su come costruire degli indicatori per valutare delle politiche è presentato nella Tabella 3.
Per quanto concerne l’Ambiente, si possono considerare i problemi dell’acqua, del suolo, della gestione dei rifiuti, del paesaggio e dei beni artistici e culturali.
In questo esempio ci limitiamo ancora agli indicatori di livello, indicatori che misurano il livello di un fenomeno in un determinato luogo.
Si tratta, tra gli altri, di quegli indicatori che misurano il consumo e l’esistenza della risorsa acqua; per quanto riguarda la difesa del suolo abbiamo la riforestazione; per quanto riguarda la vulnerabilità del sistema costruito abbiamo la superficie impermeabilizzata del territorio (indicatore importantissimo utilizzato anche a livello europeo): quella parte del territorio coperta da strade e da edifici, che è quella che ha provocato molti disastri nel nostro Paese, ecc..
Elementi di politiche basate su questi indicatori sono, per esempio, la determinazione del numero degli allacciamenti all’Acquedotto per uso civile o industriale, per quanto riguarda l’acqua; per la difesa del suolo i Piani agricoli e aziendali e di miglioramento ambientale, opere di consolidamento, monitoraggio ed adeguamento di Piani urbanistici. Indicatori di risultato applicati a politiche di questo genere, potrebbero essere il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo delle falde, come è possibile inserirsi nei progetti comunitari di risanamento ambientale e così via.
Anche per i rifiuti solidi urbani abbiamo indicatori di questo tipo.
Passiamo ora ad analizzare un altro aspetto, cruciale per la produzione di quella informazione che è in grado di “nutrire” in modo soddisfacente il processo di conoscenza e di valutazione.
Assumiamo di aver individuato le preoccupazioni e i problemi fondamentali della nostra area, del nostro oggetto di studio e di aver definito in prima approssimazione il fabbisogno informativo.
Vediamo come possiamo elaborare alcuni dati statistici per produrre informazione e vediamo quali sono gli indicatori che possiamo costruire.
Si tratta di una questione abbastanza delicata, perché purtroppo per affrontare la maggior parte delle analisi e dei problemi di pianificazione territoriale esiste ormai una sorta di tradizione, una specie di manuale degli indicatori, per cui si comincia dalla distribuzione territoriale della popolazione, delle attività economiche, da tutta una serie di analisi classiche e tradizionali e poi si traggono delle conclusioni che non sembrano provenire da questa informazione.
Spesso infatti si considera una serie di indicatori di livello di un fenomeno, riferito ad una o più zone della disaggregazione territoriale adottata (Province, Comuni, sezioni di censimento), indicatori quali il tasso di attività, l’emissione pro capite di rifiuti, gli indici di affollamento, i chilometri/giorno serviti sulla rete dei trasporti e così via.
I valori rilevati di tali indicatori chiaramente non fanno emergere connotazioni positive o negative delle varie parti del territorio, questo perché:
a) non sono stati messi in relazione con obiettivi ben definiti,
b) non sono stati messi in relazione con la struttura e il funzionamento del sistema considerato.
Quelli che invece veramente riescono a ricavare dai nostri dati molta più informazione di quanto ci si potrebbe aspettare e di quanto non facciano gli indicatori di livello prima esemplificati sono gli indicatori di sistema, indicatori che possono avvantaggiarsi della principale caratteristica della modellistica urbana, cioè quella di rappresentare le interdipendenze sistemiche.
Una città, un Comune, un’area territoriale è un sistema, il cui funzionamento, i cui problemi e in cui gli effetti di un intervento anche piccolo ci sfuggono. Si tratta di sistemi non deterministici: non ci troviamo di fronte a macchine le quali, dato un input producono predeterminabili e quindi prevedibili output.
Questo non avviene neanche con una certa probabilità più o meno alta perché in questo sistema interagiscono e lavorano continuamente elementi pianificati (il risultato delle decisioni di pochi attori) ed elementi non pianificati (il risultato delle innumerevoli micro-decisioni dei molteplici attori urbani).
Abbiamo da una parte una Amministrazione, che agisce, costruisce e gestisce le strutture e la destinazione dei suoli. Da un altro lato c’è il sistema che si autoorganizza, cioè tutti gli attori del sistema fanno le loro scelte: gli imprenditori scelgono all'interno del Piano o in variante al Piano quella che è la localizzazione di determinate attività in determinati luoghi più che in altri; dall'altra gli attori individuali, i cittadini, che si muovono attraverso la città, autonomamente decidono quale mezzo usare o quale strada usare mentre dall'Amministrazione viene una nuova struttura di mezzo pubblico o altro.
L’interazione di tutti questi comportamenti produce, per quello che interessa il pianificatore ed il gestore, dei risultati e degli effetti molto spesso sorprendenti, non aspettati, a volte inferiori a quello che ci si aspettava, a volte, in corrispondenza di un piccolo cambiamento, assolutamente superiori (Lombardo, 1991).
L’interdipendenza fra gli elementi di questo sistema così complesso ci induce a cercare di tener conto delle interazioni fra i diversi elementi e della competizione delle loro caratteristiche, incrociando le caratteristiche del sistema viario, della distribuzione delle attività della popolazione, della mobilità per scopi diversi (per mobilità si intende in questo caso non tanto la quantità di spostamenti, ma le scelte territoriali degli attori, la predisposizione a compiere spostamenti più o meno lunghi per i diversi scopi), e così via.
Per tale scopo disponiamo dei vari strumenti della modellistica urbana e territoriale.
Un esempio classico di indicatore che può trarsi da applicazioni della modellistica urbana e territoriale è l’accessibilità alle opportunità di servizio da parte degli utenti residenti in ogni sotto zona del nostro sistema, siano esse Comuni o sezioni di censimento dentro un’area urbana o altro.
“Accessibilità alle opportunità di servizio da parte degli utenti residenti in ogni zona” non indica semplicemente la quantità di tempo e/o di costo da impiegare sulla rete stradale e sulla rete dei mezzi pubblici.
Per chiarire la differenza fra indicatore di livello e indicatore di sistema è utile sviluppare un esempio: si vuole valutare l'accessibilità della popolazione ad un tipo di servizio e la sua variazione a seguito di interventi. Si tratta di un problema rilevante, infatti l’accessibilità è contemporaneamente un bene economico ed un bene sociale.
Elementi usualmente considerati sono: la dotazione (quantità di servizio disponibile pro capite), accessibilità o distribuzione spaziale (quantità che può essere misurata come quantità o quota della popolazione che ha accesso a costi inferiori ad una certa soglia).
Gli obiettivi “nascosti” sotto queste misure sono sostanzialmente: massima adesione possibile ad un livello standard di dotazione pro capite e massimizzazione della quota di popolazione che ha accesso al servizio con costi inferiori ad una certa soglia.
La
massimizzazione di questa quota di popolazione è un indicatore di
raggiungimento dell’obiettivo per la comparazione delle alternative, però è un
indicatore parziale. Infatti può accadere che la nostra analisi sia localizzata
nelle parti più fortunate, più privilegiate di un territorio, mentre forse
altre parti, che hanno un costo di accesso superiore (e in questo indicatore
non apparirebbero) sono quelle più problematiche: manca una valutazione della
distribuzione di costi e benefìci, della distribuzione di vantaggi e svantaggi
fra la popolazione localizzata sul territorio.
Per trarre questa informazione dai dati, è necessario valutare come si pone la popolazione di ciascuna zona rispetto alle opportunità offerte dall’intero sistema. In tale valutazione bisogna considerare le scelte, le sensibilità, le disponibilità a spostarsi e a spendere della popolazione, elementi, questi, che conducono ad una concezione più complessa e completa dell’“accessibilità”.
Nei due casi (indicatori di livello ed indicatori di sistema) supponiamo di avere due alternative di Piano. Che esse riguardino la distribuzione di servizi e/o la rete stradale o altro per il momento non è rilevante; è invece rilevante quale informazione ci forniscono questi due tipi di indicatori.
Nel primo caso abbiamo due alternative di Piano i cui effetti sono rappresentati dalle due linee che indicano il numero di spostamenti per la loro durata (Figura 1). In entrambi i casi in linea di massima gli spostamenti sono sufficientemente brevi, in un caso sono di più quelli brevi e poi c'è una punta di spostamenti più lunghi, che richiedono più tempo, che fanno sospettare che ci possa essere qualche area particolarmente svantaggiata da questo progetto oltre, naturalmente, ad altre particolarmente avvantaggiate; tramite questa analisi, però, non è possibile identificarle e confrontarle.
Se, invece, si applica un modello di interazione spaziale[2], da esso è possibile trarre un altro tipo di indicatore che fornisce informazioni di qualità più elevata.
Si tratta di un indicatore che misura l’accessibilità al servizio X o al pool di servizi Y come risultato dell’interazione fra domanda espressa dalla popolazione localizzata in ogni zona del sistema e una funzione (funzione entropica) del tempo di spostamento fra una zona e tutte le altre, pesata con la propensione della popolazione di quell'area a compiere spostamenti più o meno lunghi (il modello si calibra su quell'area ed ogni area avrà dei valori diversi, delle propensioni diverse per scopi diversi) per quello scopo, per quel servizio.
Ovviamente, se si tratta di scuole la propensione è una, se si tratta di ospedali la propensione è un’altra, se si tratta di servizi commerciali è un’altra ancora.
Un terzo fattore che interagisce con quelli detti sopra è la sensibilità degli utenti alle economie di agglomerazione, in altre parole, quanto l'agglomerazione del servizio produce un'attrazione per gli utenti più che proporzionale alla dimensione dell'offerta.
L'istogramma in Figura 2 ci fornisce il confronto tra la situazione attuale e gli effetti, misurati da questo indicatore, dell'ipotesi di intervento per ciascuna zona. Ad esempio, nella zona 17 l’accessibilità a quel servizio diminuisce.
Questo indicatore ci permette di giungere a delle valutazioni sulla distribuzione dei costi e dei vantaggi, dei benefìci e dei prezzi fra ogni Comune del sistema territoriale interessato o fra ogni zona della città considerata.
Questo tipo di informazione, incrociato con i dati che derivano dai rilevamenti fisici su queste aree, sullo stato socio/economico, ecc., produce un notevole livello di informazione e di conoscenza in più rispetto a quella che si poteva ottenere con il primo tipo di indicatore, e pertanto consente di costruire una più solida base su cui fondare valutazione, decisione e scelta.
4. Bibliografia
Andersson A.E., Johansson B., 1986, Livello di conoscenza, cicli produttivi e regioni metropolitane. In: Bardazzi S. (a cura), Pianificazione delle aree metropolitane, F. Angeli, Milano, 25-46.
Camagni R., 1992, Le grandi città italiane e la
competizione a scala europea. In: Costa P., Toniolo M. (a cura), Città
metropolitane e sviluppo regionale. F. Angeli, Milano, 23-46.
Clemente F., 1984, Pianificazione del territorio e sistema informativo. F. Angeli Milano
Costa, P., Toniolo, M. (a cura), 1992, Città metropolitana e sviluppo regionale. F. Angeli, Milano
Las Casas, G. B., 1984, Processo di piano ed esigenze informative. In: F. Clemente (a cura) Pianificazione del Territorio e sistema informativo. F. Angeli, Milano.
Lombardo S., 1991, Recenti sviluppi nella modellistica urbana. In: I sistemi urbani. A cura di C. S. Bertuglia e A. La Bella. Ed. Franco Angeli, Milano 1991, pag. 641-706
Lombardo S., 1994, Verso una integrazione fra modellistica urbana ed esercizio valutativo. In: L'attuazione urbanistica. Problemi e metodi di valutazione. A cura di U. De Martino e G. Rizzo, Cangemi, Roma
Lombardo S. (a cura), 1995, La valutazione nel processo di piano. Contributi alla teoria e al metodo. Franco Angeli, Milano
Lombardo S., Santini L., 1997, I Nuclei Urbani Telematici (NUT) come elementi strategici della “Rete di Area Metropolitana” di Roma. Atti della XVIII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, 271-296.
OCSE/OCDE, 1976, Mesure
du bien etre social. Parigi.
OCSE/OCDE, 1980, Les indicateurs sociaux resultats jusqu’en avril 1979
et perspectives futures. Parigi.