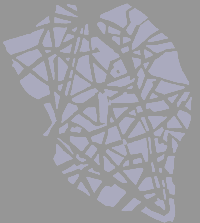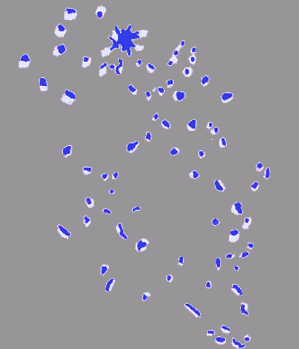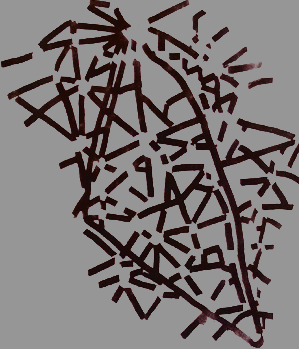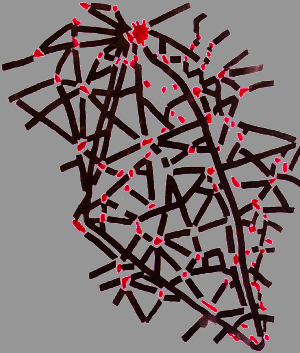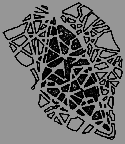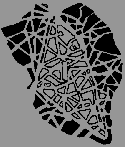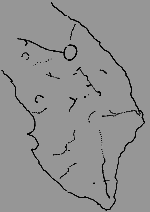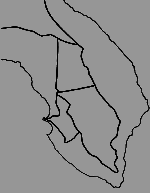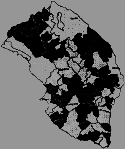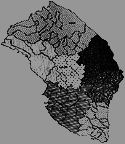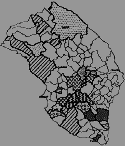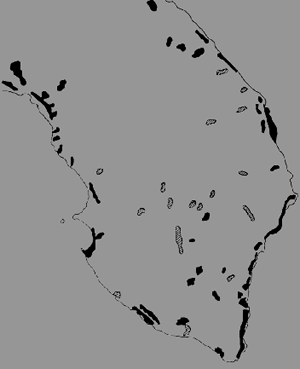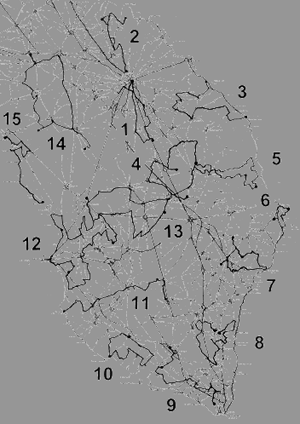Paesaggi lontani
Le tre figure illustrano i siti di interesse comunitario, nazionale e regionale, i percorsi ciclo-turistici previsti dalla Provincia e la situazione di una zona costiera ove l’abusivismo edilizio è stato particolarmente intenso.
Nel Salento i siti di maggior interesse paesistico, ambientale e storico sono diffusi; essi costruiscono un insieme di capisaldi che possono essere tra loro collegati, come si è visto nelle tavole precedenti da una maglia di corridoi ecologici, ma anche da veri e propri percorsi che possono essere frequentati dagli abitanti della regione come da un turismo sufficientemente evoluto da non accontentarsi solo dell’idea di essere vicino ad un mare che sovente non si riesce neppure a vedere.
L’urbanizzazione abusiva delle coste ha dato luogo ad alcuni delle peggiori situazioni insediative e ad un modello di sviluppo autocontraddittorio.
|
- Itinerari ciclo turistici
|
|
Paesaggi lontani
Alla crescita e sviluppo dell’economia locale, alla sua industrializzazione in particolare ed alla crescita dei servizi e delle attività terziarie a ciò connesse, al carattere endogeno dello sviluppo, alla formazione di capacità imprenditoriali e di mercati locali è affidato il raggiungimento di obiettivi fondamentali non solo in termini economici. “Riconoscere i diritti di cittadinanza, riconoscere il valore della partecipazione nella costruzione del futuro del territorio” vuol dire anche dare a queste affermazioni una dimensione concreta in termini di occupazione, di redditi, di servizi offerti, di comfort e qualità ambientale. Ma il raggiungimento di questi obiettivi non può contrastare la salvaguardia e lo sviluppo del sistema ambientale, la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico.
I temi ambientali non sono contraddittori allo sviluppo non solo nel senso banale ed elementare della conservazione e valorizzazione di “giacimenti” di risorse dotate di grande valore nei mercati turistici, ma anche e soprattutto nel senso più profondo della costruzione più lenta di una specifica cultura civile ed organizzazione sociale.
La condizione peninsulare consente al Salento diversi primati: Capo d’Otranto è il punto più orientale d’Italia, il canale d’Otranto il punto più vicino alla Grecia, la provincia leccese è quella che ha il maggiore sviluppo di linea di costa (circa 500 km.).
Una terra a doppio spiovente che partecipa di due mari e viene a giovarsi dell’azione moderatrice del Basso Adriatico cui si aggiunge quella dello Ionio e del contrasto tra questi (e che nulla può interporre alle calde ondate di venti sciroccali provenienti da sud-est).
Dal punto di vista geomorfologico essa è formata da un sistema confuso di deboli rilievi dall’andamento parallelo che si incontrano e interrompono alla punta di Capo Leuca: le Serre Salentine, costituite da una triplice successione di basse colline (non superano mai i 200 m.) corrugano appena la piattaforma peninsulare e organizzano la disposizione degli insediamenti dell’entroterra ponendoli sui versanti o nelle valli interne tra una serra e l’altra.
Le Murge presentano una netta differenza litologica che risalta successivamente nelle coperture vegetali e nell’uso del suolo: creste e altipiani calcarei del cretacico e avvallamenti interposti fasciati e ricoperti dei terreni tufacei che si insinuano un po’ dovunque, provenienti dal disfacimento dei calcari più antichi in cui si sono accumulate spoglie di organismi marini.
La parte di attacco della penisola Salentina al resto della regione pugliese, il cosiddetto istmo messapico, chiamato anche Tavoliere di Lecce, individua l’affioramento di quel calcare tenero, facilmente lavorabile, materia prima del barocco leccese.
Il territorio, appena irrigidito dall’uniformità del rilievo tabulare, presenta quindi una inaspettata ricchezza di forme, deboli dorsali con valli interne, forme del paesaggio carsico ipogee (inghiottitoi e doline) e epigee (specchie, carreggiate e rocce affioranti) che hanno fatto parlare Cesare Brandi, riferendosi a luoghi e manufatti rurali, di “orgia di pietre”.
Se le acque normalmente disegnano il paesaggio, in questo caso del loro scorrere sul terreno non si ha traccia, mancando quasi completamente forme erosive o incisioni dal momento che il regime idrografico scorre in profondità (acque di falda).
In realtà il rapporto tra queste terre e l’acqua è stato nel passato fortemente conflittuale per mancanza o troppa abbondanza di acqua: i litorali erano dominati da vaste paludi e malariche, pressocchè deserti fino agli interventi di bonifica avviati negli anni ‘20, mentre nell’entroterra le descrizioni geografiche (Sestini, 1963) parlavano di “suolo carsico estremamente bibulo dove le strade non abbisognavano di ponti” e per queste ragioni si rendeva necessario portare fin lì le estreme ramificazioni dell’Acquedotto Pugliese.
Dire che questo paesaggio viene da lontano implica il ricorso a due diverse strategie cognitive: una tende legare queste terre estreme a relazioni trans-adriatiche di varia natura (botaniche, etniche, culturali) più che ai legami continentali, come se i rapporti di continuità e di affinità fossero più forti e significativi con le terre poste al di là del mare; l’altra ci spinge a guardare nel tempo lungo del passato. Nel primo caso, da alcune letture botaniche e di fitostoria del paesaggio vegetale della Puglia meridionale, emerge il carattere bio-geografico di questa terra salentina che, più delle altre regioni dell’Italia meridionale, presenta specie a distribuzione egeica, sub-balcanica ed orientale, molte delle quali poste al limite di distribuzione più occidentale.
Nell’altro caso, guardando a ritroso nel passato, leggendo alcune descrizioni della Terra d’Otranto dei botanici di fine ‘800 e nelle reinterpretazioni cartografiche più recenti, ci appare dinnanzi un paesaggio che non c’è, che stentiamo ad immaginare perchè nulla o poco nel presente ci sembra richiamarlo. Se oggi, nel Salento, la superficie boscata è la più bassa d’Italia, meno dell’1%, in passato le terre interne erano coperte da folti boschi mesofili, cioè boschi amanti di climi umidi dove l’acqua era talmente abbondante da consentire che si praticasse la pescagione (Mainardi, 1989).
In realtà analizzando i dati pluviometrici si scopre che il Salento è una delle località più piovose della regione, con piovosità media annua superiore agli 850 mm. nel Canale d’Otranto e che, per la mancanza di uno strato vegetazionale continuo, l’acqua in parte si disperde nelle fratture del terreno calcareo e una grossa quota, data l’aridità e la sterilità dei suoli si dissolve nella evapotraspirazione.
Il paesaggio vegetazionale che oggi vediamo in questi territori, dunque, è il risultato di una lunga serie di modificazioni, di regressione e progressione dei boschi e della vegetazione spontanea in relazione alla maggiore o minore diffusione dell’agricoltura, ai rapporti sociali ed economici della rendita fondiaria che hanno profondamente coinvolto l’immagine del territorio. Le attuali conformazioni del suolo non devono quindi essere date per scontate.
Ambiente e paesaggio costruiscono diversi scenari: scenari della paura e scenari del loisir. I primi sono connessi agli elementi di rischio cui oggi siamo molto più sensibili di un tempo: alla salinità ed all’inquinamento delle falde dovuto a emungimenti ed a scarichi eccessivi ed in molti casi abusivi, al rischio di inondazioni, ad esempio nel Salento; i secondi sono connessi ai giacimenti di risorse naturali ed antropiche e possono intersecare mutamenti anche rapidi degli stili di vita.
Entro questi estremi nei quali l’ambiente diventa oggetto di una politica dei lavori pubblici o strumento di una politica del turismo, si collocano però scenari assi più interessanti. L’Italia è il paese in Europa con il più elevato grado di biodiversità e resilienza e ciò nonostante la sua antica e diffusa antropizzazione. Il Salento, tra le regioni italiane, è dotato di una biodiversità del tutto particolare, come prima è stato richiamato.
Il funzionamento e la conservazione del sistema ecologico salentino, che già di per sé è una risorsa, richiede uno specifico progetto che si fondi forse principalmente su un’idea di naturalità diffusa, non cioè sulla costituzione di grandi riserve o grandi parchi naturali, ma sulla cura meticolosa di un ambiente e di un’antropizzazione diffusa mutuamente compatibili. Molti degli schemi delle pagine precedenti forniscono alcune prime suggestioni a questo riguardo.
Un piano, il progetto di un territorio, è sempre il risultato di riflessioni che investono numerosi strati e dimensioni. Ogni strato ed ogni dimensione può essere colta in specifiche forme progettuali e in specifici tipi di rappresentazione.
La dimensione temporale, la costruzione cioè di una strategia che si distende nel tempo, la dimensione più tradizionale del dimensionamento, lo stabilire quantità edificabili in relazione ai movimenti demografici ed edilizi, la dimensione economica, la valutazione dei costi degli interventi previsti dal piano ed infine quella prescrittiva, che spazia dalla norma al consiglio, all’indirizzo, sono le dimensioni che dovranno essere affrontate nella costruzione del piano territoriale di coordinamento.
Un piano è sempre costruzione di una strategia che si dispiega in tempi e spazi differenti: in quelli dei diversi centri urbani come in quelli del territorio, nello spazio e nel tempo sociale, in quelli dell’economia, delle istituzioni, delle procedure e degli attori che per realizzare il piano si mobilitano. Una chiara strategia può consentire nel tempo la messa a punto di tattiche particolari che, entro quella stessa strategia, raccolgano le occasioni, la adattino al nuovo, la arricchiscano e la realizzino.
|